Responsabilità aquiliana da colpa medica non retroattiva: prima del 2017 vale il "contatto sociale".
- Studio Legale Fiorin

- 20 nov 2019
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 21 nov 2019
Arriva dalla Cassazione una serie di precisazioni abbastanza importanti, riguardo ai criteri di individuazione e applicazione della normativa sulla responsabilità civile dei medici e dei sanitari. In particolare, la sentenza dello scorso 11 novembre, n. 28994 (credits to Quotidiano del Diritto e Lex 24 per il testo), ha stabilito la non retroattività dell’art. 7 della Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 - cd. Legge “Gelli-Bianco” -, che dal 1° aprile 2017 a oggi sta disciplinando la natura della responsabilità degli esercenti delle professioni sanitarie.
Dunque, la collocazione ordinaria della colpa medica nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 del codice civile non è retroattiva, e può essere applicata solo a fatti commessi dopo l’entrata in vigore della suddetta legge. Per i fatti anteriormente commessi, varrà tuttora la disciplina preesistente, compresa quella del D.L. n. 158 del 2012 (cd. Decreto Balduzzi), che pur esonerando da responsabilità il medico che incorreva in colpa lieve, se nel suo operato si era attenuto alle “buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”, non aveva comunque escluso la possibilità di far rientrare la sua responsabilità nell’ambito contrattuale, con tutto quello che ciò comporta sul piano della ripartizione degli oneri probatori e della lunghezza dei termini di prescrizione.
Vale la pena ricordare che la responsabilità civile degli esercenti delle professioni sanitarie, dopo l'aumento notevole dei casi giurisprudenziali, per l'appunto era stata affrontata una prima volta nel 2012 con il suddetto Decreto Legge, che prevedeva che venisse fatto salvo “l’obbligo di cui all’art. 2043 cod. civ.”, ma non consentiva di escludere l’applicazione della disciplina della responsabilità contrattuale anche fuori dai casi in cui l’intervento medico o sanitario fosse stato espressamente contrattato tra il paziente e chi lo ha effettuato, o quanto meno tra il paziente e la struttura alla quale il responsabile apparteneva.
La giurisprudenza, infatti, aveva continuato anche dopo il 2012 a riconoscere ipotesi di responsabilità negoziale del medico sulla base del cosiddetto “contatto sociale”, cioè del rapporto che necessariamente si instaura tra il paziente e la casa di cura, così come del Servizio Sanitario Nazionale, anche in assenza di specifica contrattazione. Questa interpretazione aveva continuato, anche dopo il Decreto Balduzzi, a essere ritenuta sufficiente a far sì che gravasse sui medici l’onere di provare che nel loro operato vi fosse stata assenza di colpa se non proprio il caso fortuito.
Proprio per questo motivo, il Decreto Legge del 2012, che pure aveva cercato di limitare la responsabilità del sanitario ai casi di colpa lieve, è stato revocato dalla legge “Gelli-Bianco” che ha definito più chiaramente la materia, stabilendo che il sanitario risponde del proprio operato soltanto ex articolo 2043 del codice civile, “salvo che abbia agito nell'adempimento della obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, e cioè a seguito di una esplicita pattuizione.
La sentenza in esame ha tuttavia precisato che solo per i casi avvenuti dal 1° aprile 2017 in poi il paziente che si ritiene danneggiato dovrà in ogni caso affrontare i più severi oneri probatori connessi al regime di responsabilità aquiliana. Pertanto, dovrà provare non soltanto il fatto dannoso e il nesso di causalità tra lo stesso e i danni subiti, ma anche la sussistenza della colpa dell’esercente la professione sanitaria.
Per i fatti accaduti in precedenza, invece, potrà ancora essere applicata la teoria del “contatto sociale”, secondo la quale anche in vigenza del Decreto Balduzzi il paziente ha potuto usufruire della disciplina della responsabilità contrattuale, limitandosi a provare il fatto dannoso e lasciando che fosse il medico a dover provare non solo “di essersi attenuto alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”, ma anche di non essere incorso in colpa grave, fatta sempre salva la prova del caso fortuito.
La sentenza n. 28994 sopra indicata fa parte di un gruppo di ben dieci decisioni consecutive (numerate dal 28985 al 28994), che hanno definito altri punti incerti della attuale disciplina della colpa medica. Ad esempio, la sentenza n. 28993 ha delimitato la risarcibilità del cosiddetto “danno da perdita di chance di guarigione”, stabilendo che esso ricorra soltanto qualora sussistessero possibilità concrete di un miglioramento di salute del paziente, che certamente - e non solo probabilmente - non sono state raggiunte a causa dell’errore medico.
La sentenza n. 28986 ha invece precisato come il cosiddetto “danno da aggravamento”, o differenziale, cioè quello che si verifica a causa del fatto colposo del sanitario in una situazione di salute già compromessa del paziente (evenienza che in pratica ricorre molto spesso), debba essere quantificato con una valutazione per sottrazione. Il giudice dovrà cioè calcolare l’invalidità complessiva dell’individuo all’esito dell’intervento e la somma risarcibile in base a essa, e poi sottrarre da quest’ultimo importo la somma di denaro che occorrerebbe per risarcire l’ipotetica invalidità preesistente, o comunque quell’invalidità che sarebbe comunque sussistita dopo l'intervento anche in assenza dell’errore medico. Quest’ultima percentuale di invalidità dovrà essere individuata con una stima di carattere equitativo, fatta salva la possibilità del giudice di applicare la equità correttiva, qualora il criterio differenziale sopra spiegato porti a risultati manifestamente poco equi nel caso concreto.

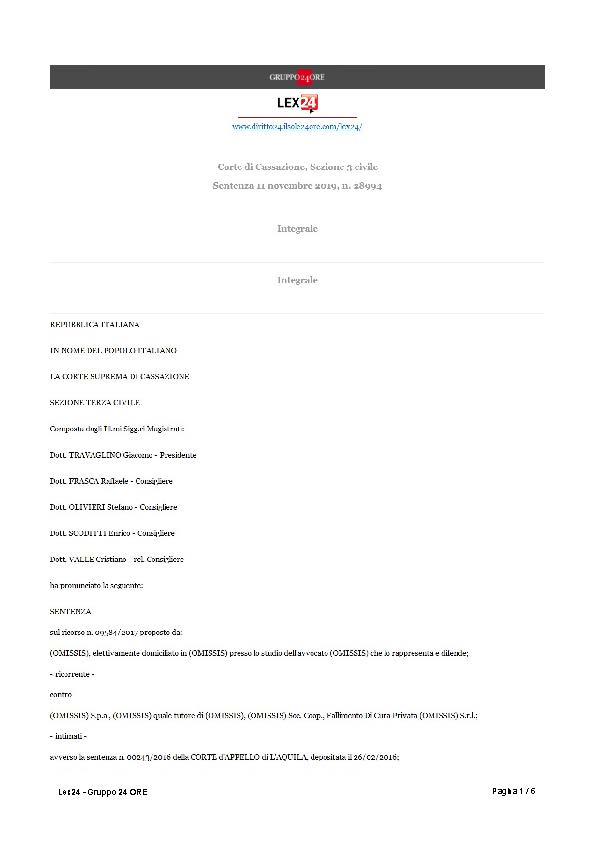

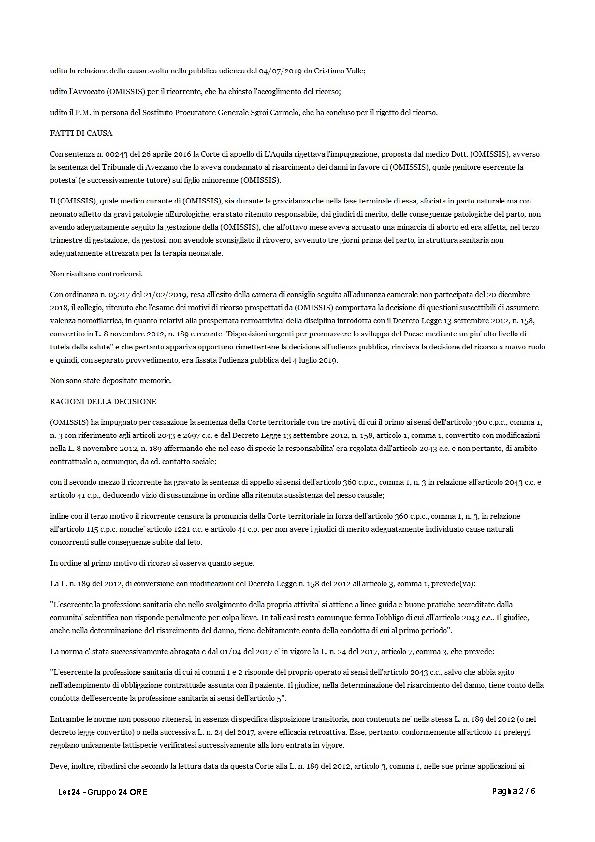
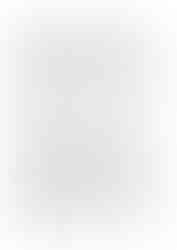
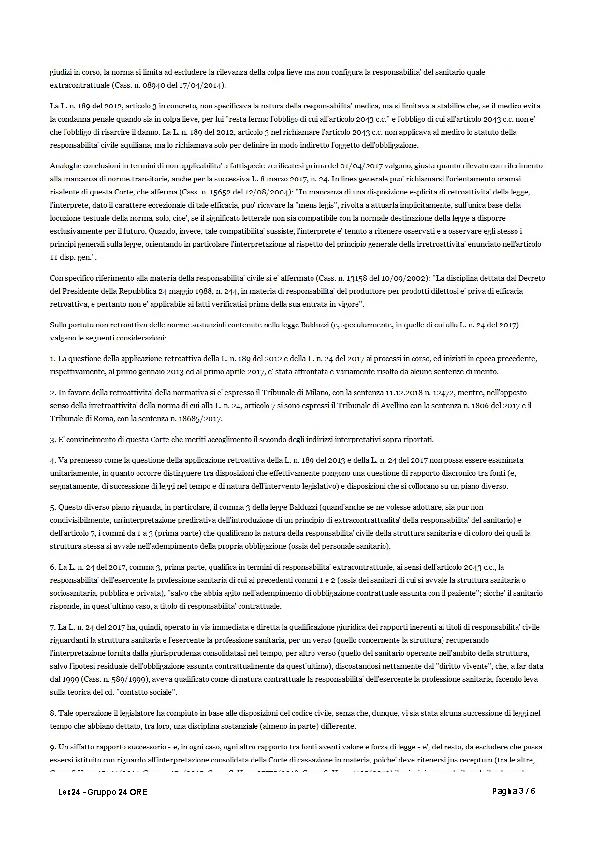


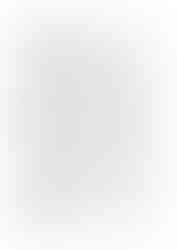
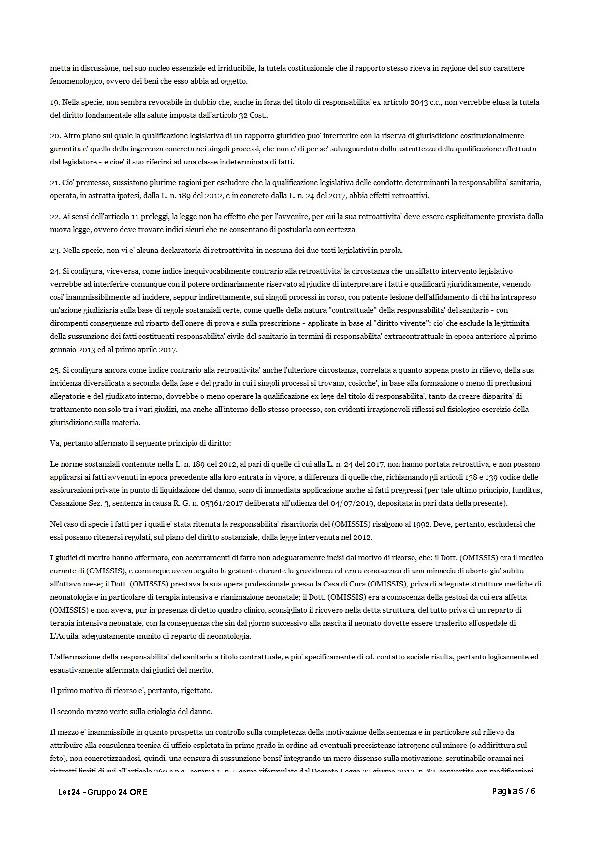

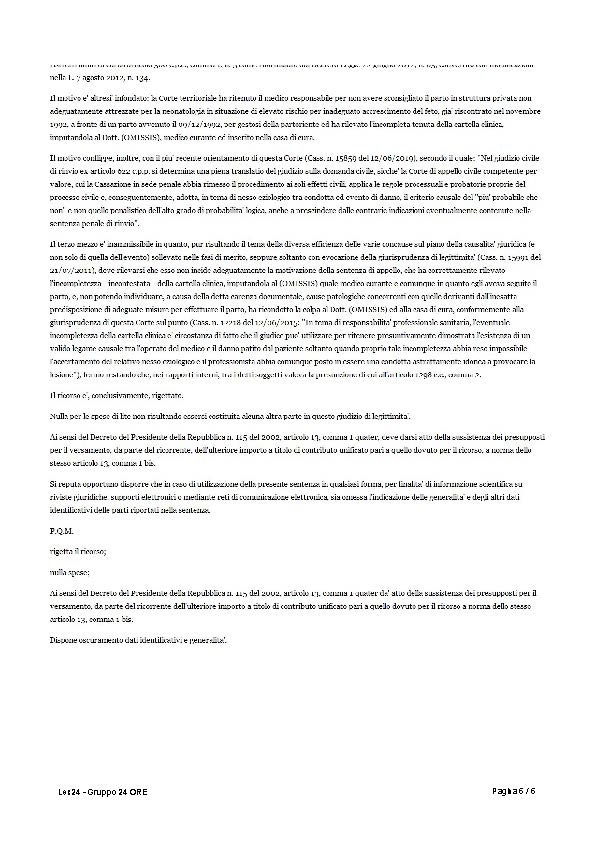



Commenti