Danno endofamiliare: padre responsabile dei "disagi" della figlia senza poter delegare alla madre.
- Studio Legale Fiorin

- 28 mag 2019
- Tempo di lettura: 4 min
Nuovo arresto della Corte di Cassazione (Sezione III Civile, ordinanza di rigetto n. 14382 del 2019) sul tema dei danni morali endofamiliari, cioè della tipologia di danno non patrimoniale - che ormai ha numerosi e acclarati precedenti in giurisprudenza - derivante dall'insufficiente adempimento degli obblighi affettivi verso i figli e/o verso il coniuge.
Ancora una volta, l'impressione è che a dover risarcire l’equivalente economico delle conseguenze delle proprie inadeguatezze sia sempre e comunque il padre, anche nei casi in cui gli oneri della paternità erano stati rifiutati fin dall'inizio, indipendentemente dal riconoscimento del figlio, persino se in accordo con la madre.
Quest'ultima, invece, se si scorrono i vari precedenti in materia, sembra trovarsi più al riparo dall'eventualità di sentirsi citare in giudizio dalla prole o dal partner, per risarcire la propria inadeguatezza. A voler essere maliziosi - o forse solo realisti - questo dipende non solo da ragioni di carattere sociale e economico, ma anche dal fatto che c’è una sorta di cattiva coscienza collettiva riguardo al fatto che la madre - al contrario del padre - ha il diritto di non assumersi gli oneri della maternità, se non con l’aborto, con l’istituto della “madre segreta”, cioè dell'abbandono alla nascita.
Nel caso di specie, si era trattato della figlia naturale riconosciuta da un signore siciliano oggi settantaduenne, che dal momento della nascita, ben quarant'anni prima, non aveva voluto farsi carico dell'educazione e dei bisogni della ragazza, lasciando che ad essi provvedesse principalmente, per tacito accordo, la madre con la quale la stessa era cresciuta (per i particolari cronologici, v. “Quotidiano del Diritto” del Sole 24 Ore, che nel commento alla sentenza in esame del 28 maggio 2019 ha dimostrato di conoscerli, anche se non risultano dal testo dell’ordinanza).
Una volta diventata adulta, la figlia ha deciso di chiedere al padre il risarcimento di danni morali e patrimoniali, con tanto di danno da perdita di chance, sostenendo di avere a lungo subito negli anni della sua maturazione psicofisica un “disagio” affettivo, a causa dello scarso supporto, non solo economico ma anche morale, che le era pervenuto dal padre. Questa situazione l’avrebbe portata a lasciare l'università, con conseguente perdita di opportunità di carriera e di realizzazione personale.
I magistrati di legittimità hanno accettato il principio per cui la mancata sollecitudine del padre rispetto alle esigenze morali e patrimoniali della figlia avesse potuto essere la causa efficiente delle “difficoltà di vario genere nella serenità personale della ragazza, e complessivamente nello sviluppo della sua personalità, tra le cui ulteriori conseguenze vi è stata anche quella della sua scelta di un’anticipata interruzione degli studi”. Vale a dire che, secondo la Suprema Corte, si può ritenere provato il nesso di causalità tra la scarsa presenza - non solo economica ma anche affettiva - del padre e gli insuccessi studenteschi della prole, tanto che nel caso di specie questa si è vista confermare il diritto a un risarcimento comprensivo da “perdita di chance”, quantificato in via equitativa (non potendo essere altrimenti) in quasi 67 mila euro.
La Cassazione ha dunque ribadito che “la responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione gravano su entrambi i genitori e non solo su quello convivente, e nascono dal fatto stesso della filiazione, senza potere essere delegati all'altro genitore”. Infatti, il malcapitato settantaduenne si era difeso sostenendo che fosse sempre esistito un tacito accordo tra lui e la madre, per cui sarebbe stata solo quest’ultima a occuparsi in via diretta e immediata delle eventuali difficoltà scolastiche, morali e esistenziali della figlia convivente. Era tra l'altro risultato in giudizio che la madre, pur conoscendo le “problematiche comportamentali” della figlia, non ne aveva mai preso atto e non era a sua volta mai intervenuta nei limiti del possibile, ma anche questo è stato giudicato irrilevante, a prescindere dall'ipotesi astratta di un diritto di regresso verso la corresponsabile, perché nel merito questo non era stato azionato.
Tuttavia, secondo la sentenza in esame, il particolare della "delega" consensuale alla madre convivente sarebbe in ogni caso da ritenersi non esimente dalla piena responsabilità paterna. Sarebbe infatti da rigettare la tesi per cui, in caso di un singolo genitore “assente”, la responsabilità di intervenire tempestivamente per evitare che i figli possano subire danni da carenza affettiva e di supporto economico si trasferisca sull'altro genitore, anche qualora lo stesso abbia accettato liberamente di essere l'unico “presente” nella vita quotidiana della prole.
Il principio può apparire giustificabile, se non fosse che è difficile stabilire un preciso nesso di causalità tra i problemi esistenziali dei figli, con i loro eventuali scarsi successi scolastici e/o lavorativi, e il comportamento dei genitori. Il rischio è che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, ma anche di assisterla moralmente, finisca per comportare come esito necessario - con conseguenze diaboliche sul piano probatorio - una sorta di “diritto al successo” negli anni della crescita e della formazione della personalità.
La decisione appare dunque poco equilibrata, anche se esistono precedenti anche più radicali in tema di danno endofamiliare, sempre a carico del padre. Addirittura, in caso di figli nati da relazioni adulterine tenute a lungo nascoste da parte della madre, è successo che, una volta scoperta la vera situazione, il padre naturale abbia subito su istanza del figlio non riconosciuto una pesante condanna risarcitoria, per essersi sottratto a quegli obblighi che - per principio ormai ammesso dalla giurisprudenza unanime - nascono dalla paternità in sé stessa fin dalla nascita (la sentenza in esame ha citato una lunga serie di precedenti al riguardo).
In certi casi si è persino liquidato una sorta di danno “differenziale” per la perdita di opportunità che il figlio ha subito, per il fatto in sé di essere cresciuto come figlio legittimo di un soggetto con molte meno possibilità economiche del padre naturale. In questi casi non si è posta nemmeno la tesi di per sé assurda, ma logicamente conseguente, per cui, laddove il padre legittimo fosse stato molto più ricco, allora questo avrebbe potuto vantare il diritto di farsi risarcire dal padre naturale, per avere cresciuto suo figlio nel benessere e nelle opportunità che il predetto non avrebbe potuto garantirgli.
Ma questa, in fondo, è solo la dimostrazione che alla base di queste decisioni ci sono soltanto delle convenienze patrimoniali. La morale è che essere padre significa sempre doversi fare carico della felicità dei figli, anche se, come a volte capita nella vita e non sempre per propria colpa, c'è qualcun'altro che abbia preso il proprio posto.
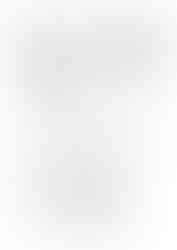
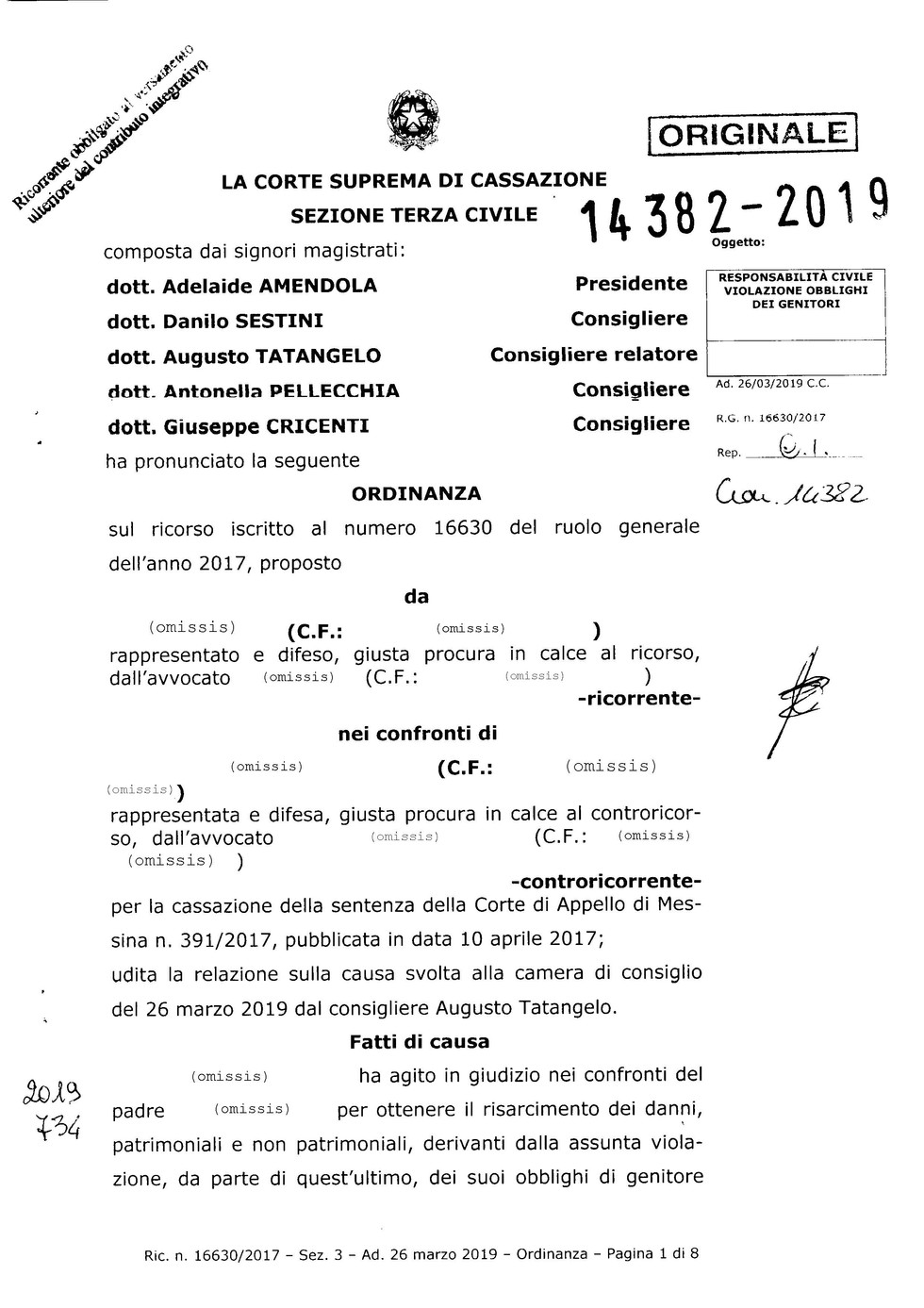



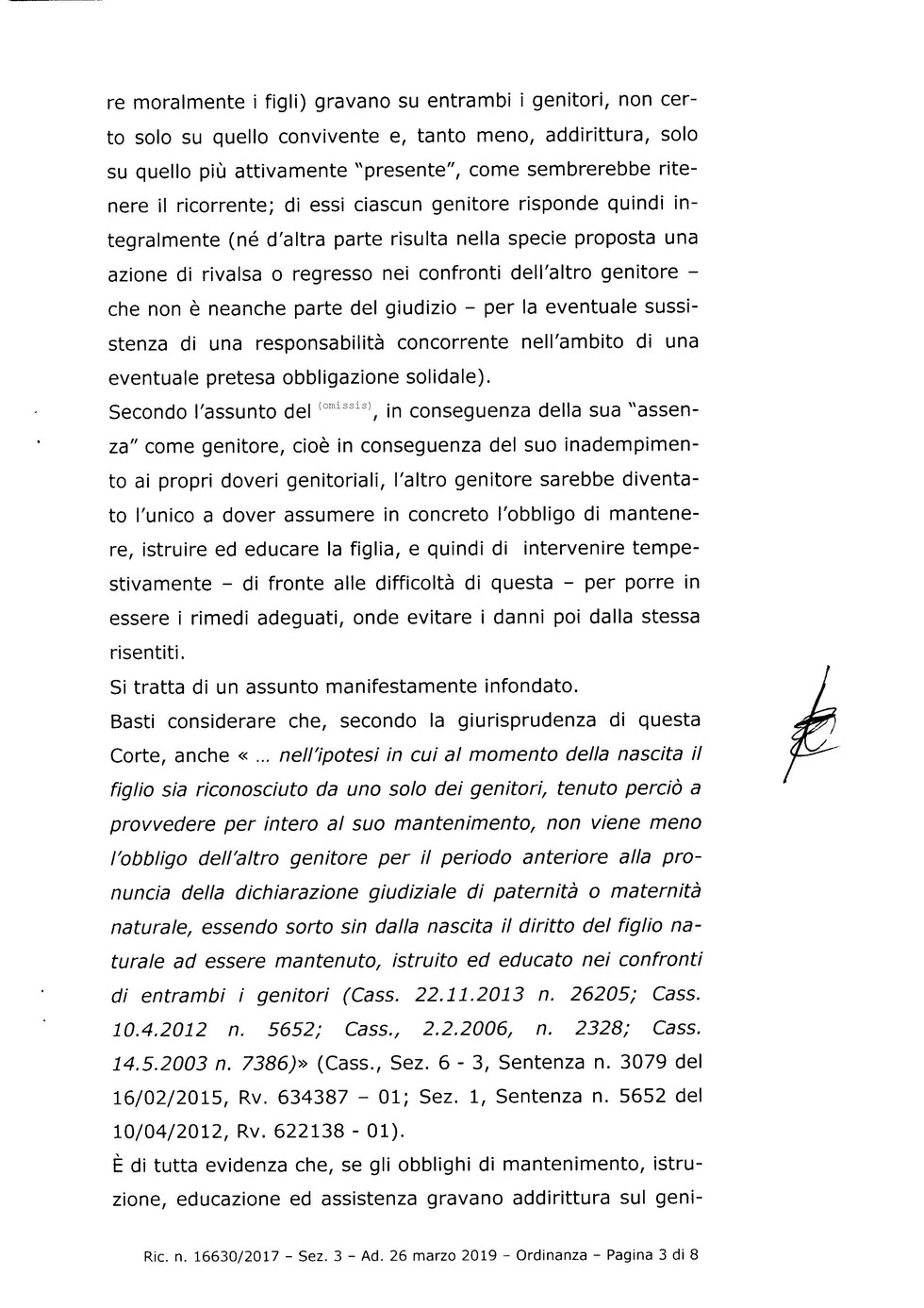













Commenti